Cerco l’incontro onesto, crudo e senza filtri

Jerzy Grotowski, tra i più grandi maestri della ricerca teatrale, diceva che il teatro, nella sua vera essenza, «serve a superare le frontiere tra me e te: arrivare ad incontrarti per non perderci più tra la folla, né tra le parole […]. Non nascondermi più, essere quello che sono. Almeno qualche minuto, dieci minuti, venti minuti, un’ora. Trovare un luogo dove tale essere in comune sia possibile». C’è una certa somiglianza tra le sensazioni evocate da queste parole e quelle provate nella particolare, decisamente inedita esperienza scenica – per 12 o 18 spettatori/partecipanti alla volta –, riconducibile all’artista sarda Alessandra Asuni. È la trilogia rituale di Accabbai (sarà a Cagliari dal 20 al 22 ottobre e a Leverano dal 2 al 4 novembre), Matrici e Sabi (a Napoli a dicembre), dedicati a morte, nascita e guarigione: tre momenti critici dell’esistenza e complementari come il nero, bianco e rosso che li rappresentano, narrati attraverso tradizioni remote di una terra ancestrale e misteriosa come la Sardegna.
S’ispira alla Femina Accabadora, Accabbai (a cui collaborano Marina Rippa e Massimo Staich), colei che – fino a non troppi decenni fa –, su richiesta della famiglia, praticava l’eutanasia ai moribondi. S’ispira all’attimo più sacro e comune di tutti, la nascita, la Asuni partoriente, levatrice e Madre di Matrici. E s’ispira a cure antiche – forse di magia, forse di fede –, l’ultimo rito, Sabi, dove la malattia esorcizzata è atto condiviso di rinascita.

Alessandra Asuni, dopo un lungo percorso da attrice, com’è arrivata a concepire questa trilogia?
Fare la scritturata non mi bastava più. Interpretare un ruolo era diventato insufficiente, quasi limitativo. Allora ho scritto e diretto Mamma compie 70 anni, intorno a Garcia Lorca, all’amore e alla morte, ma avvertivo che qualcosa non andava: volevo raccontare i dettagli, volevo che le persone mi stessero più vicino, sentissero il contatto con un oggetto, uno sguardo, un respiro. Ero in crisi. E per uscirne dovevo rischiare, sbagliare forse. E così feci: il primo rischio fu Accabbai. Era il 2011.
Perché Accabbai?
Mi affascinava la figura dell’Accabadora: sapevo che attraverso lei potevo parlare della mia memoria rispetto alla mia terra, la Sardegna. E volevo che lo spettatore partecipasse totalmente, che fosse parte di una comunità. Così nacque il primo esperimento: dieci persone in un sotterraneo a Napoli.
Ora però gli spettatori sono dodici. Perché?
Dieci mi sembrava il numero giusto, ma ho capito subito che era necessario fossero dodici: io dovevo essere la tredicesima, in quest’ultima cena. E mi rendo conto che ogni volta il rito (che ha azioni codificate) si rigenera; si riempie di piccole novità, fosse anche un minimo gesto o una parola che, a volte, trattengo nella vita dello spettacolo, e un po’ anche nella mia.
Il suo è teatro nel senso più umano del termine: cerca il contatto, l’incontro…
Per me il contatto è fondamentale, il teatro è fondamentale. E il teatro comprende diversi linguaggi ed espressioni che si amalgamano, si contaminano: fa parte della sua bellezza. Ma spesso, quando non si riesce a identificarli chiaramente, si fatica a riconoscere tale commistione come forma teatrale. Perciò sono in disaccordo con chi mi dice “questo non è teatro”: io vengo dal teatro, da anni di studio e ricerca teatrale, senza i quali, probabilmente, non lavorerei così. Nella mia ricerca pongo il problema dello stare in scena, del vivere totalmente una situazione, viverla insieme, come una catarsi collettiva. Cerco un’empatia, anche con gli spettatori, che ci permetta di emozionarci, di vederci reciprocamente: vederci da vicino e scoprire il mondo che c’è dentro l’altro. Ecco: è questo che mi succede con i riti. Non pensavo potessi provare queste sensazioni, quando debuttai con il primo.

Col suo teatro, cosa cerca?
Cerco l’umano. L’incontro onesto, nudo, senza filtri, né maschere. Mi accorgo, durante i riti, che le persone si lasciano andare a una comunicazione sincera, leale. Si crea un legame autentico che mi manca quando interrompo le repliche, mi manca tantissimo.
Un bisogno esistenziale prima ancora che professionale?
Sono attratta dall’antropologia, dai misteri della vita e della morte, dalla curiosità per l’essere umano e il suo affrontare temi così importanti: interrogativi enormi ai quali cerco di avvicinarmi attraverso il teatro. Quando riprendo i riti mi avvicino un po’ a questi misteri, e a quelli di chi si siede con me. È lì, tra loro, con loro, ogni volta, mi perdo.
Cioè?
Subisco emotivamente la performance: ho bisogno di riprendermi, e a volte non sto bene per un po’. E non sono la sola: ci sono spettatori che mi confidano di sentirsi, in un certo senso, disorientati. Con Matrici, per esempio, molti, anche a distanza di tempo, mi dicono che era la prima volta che qualcuno gli chiedeva di raccontare la propria nascita: è qualcosa che ci lascia piacevolmente impreparati.

Per i riti sceglie spesso luoghi non convenzionali e ne fa suoi habitat. Ma cos’è per lei lo spazio scenico?
Un posto in cui stare. Devo spendere del tempo nello spazio che accoglierà un rito. E devo farlo da sola. Sola, non in solitudine. Infatti, in questi spazi sempre un po’ antichi, magari trascurati e caotici – e più lo sono, più li preferisco –, ho l’impressione che ci sia qualcun altro, qualcuno che appartiene al passato che vive con me quel presente. Sto lì: osservo gli angoli, le tonalità di luce. Ascolto le mie sensazioni. Poi attuo una sorta di training: ripulisco, spolvero, sistemo. Voglio farlo mio, quel luogo. Ne studio la geometria, cerco le linee del cerchio e del quadrato, cioè il femminile e il maschile, che incastro l’una nell’altro, perché non credo possano esistere l’una senza l’altro e viceversa. E poi trovo posto agli oggetti, sia pure una semplice pietra o un mazzetto d’erbe: li metto là dove mi sembra stiano da secoli.
Questo vale anche per Apnea, un altro suo progetto.
Apnea, presentato all’ultimo Napoli Teatro Festival, è dedicato alla donna che scende sott’acqua e prende il bisso vivo: l’ultima donna al mondo che fila la “seta di mare”. È una performance con più persone, in una stanza piena di sale e acqua. Anche qui mi concentro sulla relazione tra corpo e istallazione, corpo e luogo: amo l’idea che anche se io vado via, gli spettatori possano continuare a vivere quel posto, percepirne il permanere di un abitare, di una storia, di una presenza.
Cos’è cambiato in lei dopo i riti?
Ho imparato ad ascoltare di più, soprattutto il linguaggio non verbale mio e degli altri. Ho imparato un nuovo modo d’intendere il tempo: per me il tempo non esiste. Nel senso che nelle due o tre ore nelle quali ripeto il rito, non vivo un tempo chiaro: è come se fosse sospeso, o appartenesse a un’epoca “altra”. Ore nelle quali qualcosa di molto forte mi piomba addosso: qualcosa che mi permette di guardare dentro gli occhi di chi ho di fronte, e vederci sguardi e mondi che appartengono a cent’anni fa.
Articolo tratto dal numero di Tempi in edicola e pubblicato su Tempi il 1 novembre 2017
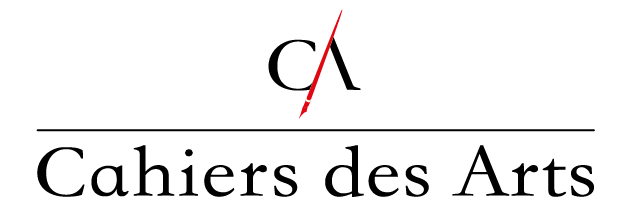





0 comments